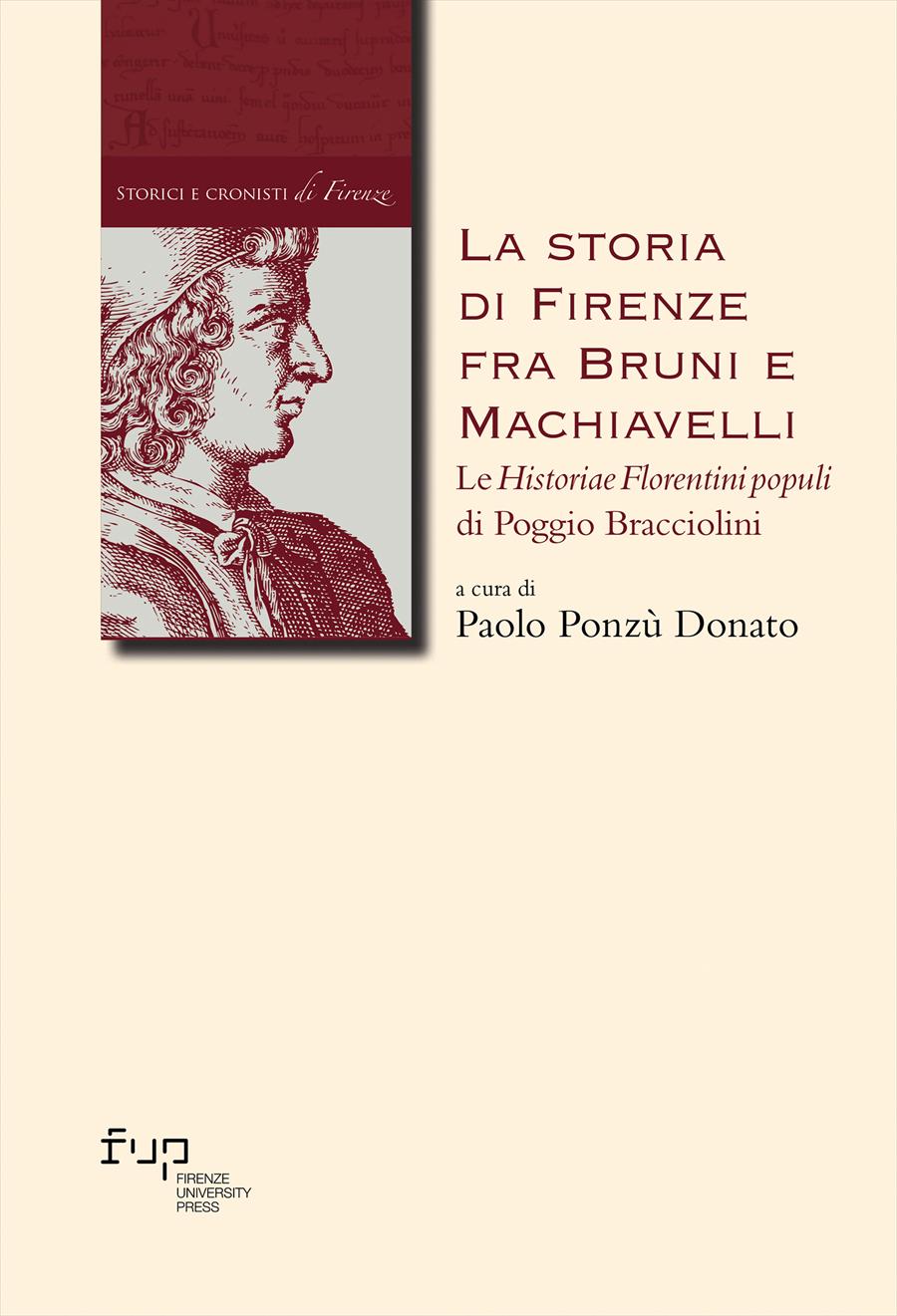
Altre news
La storia di Firenze fra Bruni e Machiavelli
Le Historiae Florentini populi di Poggio Bracciolini
15/05/2025
«Ego civis Florentinus ex municipio Terraenovae»
Tracciare la biografia di Poggio equivale a ripercorrere, nelle sue linee fondamentali, il processo di transizione tra Umanesimo e Rinascimento, ovvero tra la fase pionieristica della riscoperta anche materiale dei classici e la fase della riflessione e dell’inquadramento critico della storia, del pensiero e della lingua degli antichi. Tra la generazione, per intenderci, di Salutati, Bruni, Aurispa e Guarino a quella di Valla, Poliziano, Ficino e Biondo. Questa transizione culturale si sovrappone, a Firenze, ad una transizione sociale e politica, dalla città medievale e ‘repubblicana’ a quella medicea, che di repubblicano conserverà soltanto il nome. «Io sono un cittadino fiorentino del municipio di Terranuova» rivendica orgoglioso Poggio nella sua invettiva contro Tommaso Morroni da Rieti (In T homam Reatinum spurcissimum ganionem), ed è in questo duplice statuto di cittadino e ‘provinciale’ che bisogna leggere il suo percorso umano e culturale. Nato a Terranuova (oggi ribattezzata in suo onore Terranuova Bracciolini) nel Valdarno superiore l’11 febbraio 1380 da Guccio, speziale, e Iacoba Frutti, il cui padre era notaio, studiò prima ad Arezzo, dove si era trasferito con la famiglia, e poi, entro la fine del secolo, a Firenze, per essere avviato alla professione notarile. Guccio infatti era caduto in rovina per non aver onorato i debiti contratti con un usuraio e fu costretto alla fuga, come ricorda Coluccio Salutati in una lettera a Pietro Turchi del 18 ottobre 1401 (Ep. 12.23). Dall’opera che qui viene pubblicata apprendiamo alcune notizie inedite sulla famiglia e sulla giovinezza di Poggio. «Ricordo che quand’ero piccolo mio padre prese le armi, dato che i nemici si avvicinavano ai bastioni del castello di Terranuova, e andò contro i loro cavalieri insieme agli altri abitanti per difendere la patria» (§ 3.18.1): siamo nell’aprile del 1390 e i nemici di cui parla l’umanista sono le truppe viscontee guidate da Giovanni d’Azzo degli Ubaldini. «Io stesso, quand’ero giovane, presi la veste nel mio paese natale e a piedi nudi mi unii ai miei parenti, cantando inni in lingua volgare e lodi a Dio, e dopo nove giorni, in cui viaggiammo verso Cortona e i paesi vicini dedicandoci al digiuno e alla preghiera, feci ritorno a casa» (§ 3.61.7): l’anno è il 1399 e Poggio ricorda così la sua adesione alla Devozione dei Bianchi (dal colore della veste di cui parla l’umanista), movimento religioso popolare che chiedeva a gran voce la pace per la martoriata Italia. Per mantenersi agli studi, il giovane Poggio intraprese una brillante carriera di copista, sviluppando, in collaborazione con Niccolò Niccoli, quella che diventerà presto la scrittura umanistica per eccellenza, nota appunto come ‘scrittura umanistica’, o littera antiqua, che in realtà recuperava la tradizione scrittoria carolingia. I codici da lui esemplati suscitarono l’ammirazione dei maggiori umanisti del tempo, tra cui lo stesso Salutati e Leonardo Bruni, conosciuto forse già durante il soggiorno aretino. Fu proprio Bruni ad indurre Poggio a cercare fortuna a Roma, ove in un primo momento trovò impiego come segretario del cardinale Landolfo Maramaldo (1350/5-1415), vescovo di Bari, ma grazie al Salutati ottenne un posto come scrittore apostolico presso la Curia pontificia, seguendo prima i papi legittimi Bonifacio IX, Innocenzo VII e Gregorio XII e poi gli antipapi Alessandro V e Giovanni XXIII, che lo promosse al rango di segretario apostolico. Nel 1415, con la deposizione di Giovanni XXIII a Costanza, vi si trattenne in attesa delle decisioni del Concilio, che di lì a poco avrebbe ricomposto lo Scisma d’Occidente, dedicandosi nel frattempo ad un’instancabile ricerca di manoscritti presso le biblioteche monastiche in Germania, Svizzera e Francia. Poggio, d’altronde, era avvezzo a simili esplorazioni, avendo già visitato nel 1407 le biblioteche di Montecassino e di Napoli, ma fu nel 1415 e soprattutto nel biennio 1416-17 che riuscì a compiere le scoperte più clamorose. Nella primavera del 1415 reperì le orazioni ciceroniane Pro Murena e Pro Sexto Roscio in un codice dell’abbazia di Cluny, mentre nell’estate dell’anno seguente si recò nel monastero di San Gallo insieme a Cencio de’ Rustici e Bartolomeo Aragazzi da Montepulciano scovando, tra l’altro, un codice delle Institutiones oratoriae di Quintiliano, parte degli Argonautica di Valerio Flacco, il commento di Asconio Pediano a cinque orazioni di Cicerone e un commento anonimo a quattro Verrine. Nel gennaio del 1417, ancora con Bartolomeo Aragazzi, tornò a San Gallo e in altri monasteri nelle vicinanze, trovando esemplari dell’Epitoma rei militaris di Vegezio. Partito poi da solo in Germania nella primavera di quello stesso anno, riuscì a reperire il De rerum naturae di Lucrezio, gli Astronomica di Manilio, i Punica di Silio Italico, le storie di Ammiano Marcellino. In estate si diresse nuovamente tra Germania e Francia, ricavando, tra l’altro, un notevole bottino ciceroniano: a Langres trovò infatti l’orazione Pro Caecina, e altre otto orazioni (Pro Roscio comoedo, tre De lege agraria, Contra Rullum, Pro Rabirio, In Pisonem e Pro Rabirio Postumo). La portata di simili scoperte, prontamente comunicate ad umanisti come Bruni, Niccoli, Ambrogio Traversari, Guarino Veronese e Francesco Barbaro, oltre alla realizzazione di copie nella sua caratteristica grafia, resero presto famoso il nome di Poggio, ma non abbastanza da consentirgli il rientro in Curia presso il nuovo papa Martino V. Nel 1418 partì dunque per l’Inghilterra al servizio del cardinale Enrico Beaufort (c. 1374-1447), vescovo di Winchester, restandovi per cinque anni. Il soggiorno segnò tuttavia una battuta d’arresto per i suoi studi, che poté riprendere con soddisfazione solo quando, nel 1423, Martino V lo reintegrò come segretario apostolico. Già nel viaggio di ritorno in Italia recuperò il frammento più ampio del Satyricon di Petronio, avviando presto nuove campagne di ricerca a Montecassino, ove nel 1429 scoprì il De aquaeductibus di Frontino e i Matheseos libri di Firmico Materno, alternando all’ufficio di segretario la trascrizione di epigrafi e la raccolta di statue, gemme e monete antiche. Morto Martino V, Poggio seguì il suo successore Eugenio IV (1431-47) nei suoi spostamenti a Firenze, Bologna, Ferrara e Siena. Il ritorno in Toscana gli consentì di riabbracciare i vecchi colleghi, nonché di stringere un forte legame con la casa medicea, in particolare con Cosimo e suo fratello Lorenzo. Finalmente, nel 1436, contrasse matrimonio con la diciottenne Vaggia (o Selvaggia) Buondelmonti, da cui ebbe sei figli: cinque maschi (Pietro Paolo, Giovanni Battista, Iacopo, Giovanni Francesco e Filippo, tutti avviati alla carriera ecclesiastica, a parte Iacopo) e una femmina (Lucrezia). Due anni dopo acquistò una casa in campagna, la cosiddetta ‘Valdarnina’, non lontano da Terranuova, che divenne presto il suo buen retiro. La sorte sembrava arridere a Poggio quando, nel 1447, fu eletto al soglio pontificio l’amico Tommaso Parentucelli, che assunse il nome di Niccolò V, ma la precaria situazione politica della Curia e le violente polemiche intrattenute in particolare con Lorenzo Valla e Giorgio di Trebisonda lo indussero a lasciare Roma nel 1453 per accettare l’incarico di cancelliere della Repubblica di Firenze.